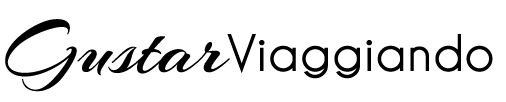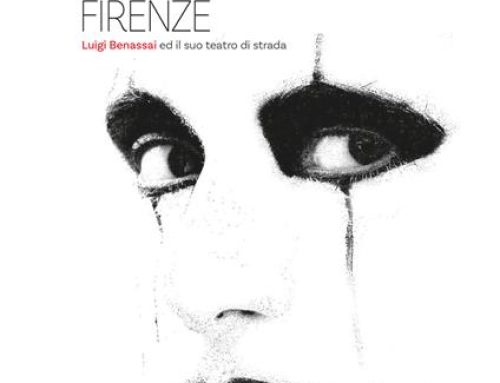Le notti di Salem (Salem’s Lot) di Stephen King, secondo suo libro dopo Carrie, è veramente un affresco dalla terribile e policroma coralità. Il vampirismo diventa l’occasione – una grande opportunità còlta nella sua interezza – per tratteggiare un’America dei primi anni ’70 del ‘900 che, pur nei manifesti ed esplicitati riferimenti dell’Autore (si legga la sua postfazione) al Dracula di Bram Stoker, al Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e ai fumetti dell’EC Comics, non può non trasformarsi in una sorta di aggiornamento – molto sui generis – dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Poesia, arte paesaggistica e gusto per le descrizioni dei molti microcosmi che concorrono a formare ogni complessa realtà: ecco alcuni degli altri ingredienti di questo grande romanzo dell’orrore.

La casa di KIng
Gli Ingredienti
Già, gli ingredienti. Non è facile pensare all’enogastronomia ragionando di un libro horror. Per lo meno occorre scartare di lato e affiancare il tema da un punto di vista completamente diverso.
Tuttavia, qualcosa si può fare e dire. È talmente vasto il coro di personaggi disegnato da King e così varia la sua umanità che è impossibile soffermarsi sulle (poche) singole citazioni, come invece altre volte ci piace fare. Possiamo però concentrarci su due momenti della storia, senza peraltro rivelare praticamente niente né della trama né della sua conclusione, che lasciamo entrambe al lettore.
Il primo momento è rappresentato dalla cena organizzata per presentare il protagonista, lo scrittore Ben Mears, alla famiglia della sua nuova fidanzata, Susan Norton, un amore nato al suo ritorno al paese di Jerusalem’s Lot. Qui, più che pietanze e vivande, contano il loro valore umano ed empatico.

Il padre di lei, Bill Norton, è persona schietta e diretta e non ama molto quelli che definisce come ‘artistoidi’. Il suo approccio di conoscenza passa innanzi tutto dalla stretta di mano – “forte e sicura”, quella di Ben –, alla quale segue il “test numero due. ‘Una birra? Ne ho messa un po’ in ghiaccio.’ Indicò il patio sul retro della casa, costruito da lui stesso. Gli artistoidi fumosi dicevano invariabilmente di no, si facevano quasi tutti di erba e non avrebbero annegato la loro preziosa coscienza nell’alcool. ‘Una birra senz’altro’, rispose Ben e il suo sorriso diventò malizioso. ‘E poi magari anche una seconda o una terza.’
Nella casa rimbombò la risata di Bill. ‘Okay, sei il mio uomo. Andiamo’ […] Ben seguì Bill in veranda. Su uno sgabello, nell’angolo, c’era un secchiello con del ghiaccio e alcune lattine di Pabst. Bill ne prese una e la lanciò a Ben, che la acchiappò al volo, ma con delicatezza, perché non facesse schiuma […]. Ben bevve una lunga sorsata e poi ruttò, altro punto a suo favore […] ‘Ti va di darmi una mano con gli hamburger e gli hot dog?’ ‘Sicuro.’ ‘Gli hot dog vanno tagliati per far venir fuori il succo. Lo sai questo?’ ‘Sì.’ Tracciò dei tagli in diagonale nell’aria con l’indice destro, vagamente divertito. I tagli nelle salsicce servivano a impedire che scoppiassero. ‘Si vede che sei di queste parti’, concluse Bill Norton. ‘Molto soddisfacente. Prendi quella carbonella laggiù e io vado a prendere la carne. E portati dietro la birra.’ ‘Non me ne separerei mai.’”.

Ci sentiamo tutti un po’ come il James Stewart della Finestra sul cortile di Alfred Hitchcoc
Il secondo “momento enogastronomico” de Le notti di Salem che ci piace ricordare è esemplare della tecnica e della padronanza narrativa di King, il quale, per descrivere un passaggio cruciale della storia, uno dei più importanti (che naturalmente non sveleremo), si affida alle cene private di diversi personaggi, in una sorta di cronaca insieme poetica e documentaristica dalla grande efficacia.
Scorrono davanti ai nostri occhi nella dimensione della contemporaneità le immagini: del petto di pollo e della tazza di tè Lipton di Mabel Werts; dei fagioli in scatola dei pensionanti di Eva, “così tristemente diversi dai fagioli che le loro madri mettevano sul fuoco il sabato mattina e facevano cuocere per tutto il pomeriggio, spaghetti, o hamburger riscaldati presi al McDonald’s di Falmouth tornando a casa dal lavoro”.
Dei sandwich mangiati in cucina dai coniugi Petrie; del pane e latte di Milt Crossen; dei cinque hamburger di Delbert Markey “che si è fritto da sé. Li mangia con senape e una montagna di cipolle crude”; delle cotolette di maiale di Harriet Durham e famiglia; della patata lessa accompagnata da una bottiglia di spuma di Carl Smith; del prosciutto con cavolini di Bruxelles dei Boddin; e delle “bistecche, mais surgelato, patatine fritte e, per dessert, un budino al cioccolato con crema” dei Sawyer.

Grazie alla sapienza descrittiva di King, ci sentiamo tutti un po’ come il James Stewart della Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Guardiamo il mondo dal nostro obiettivo (o da un oblò!) e osserviamo il viaggio di decine di persone attraverso la lente di ingrandimento delle loro cene parche, frivole, eccessive, mediocri, ordinarie, sbadate, pensierose, male assortite, icasticamente simboliche.
Salutiamo infine il secondo romanzo dello scrittore statunitense non senza ricordare che, sebbene non se ne sia parlato, un elemento in qualche misura gastronomico che lo attraversa e lo unifica ovviamente c’è e, in un modo o nell’altro, scorre e occupa, silente o presente, l’intera opera. Trattando il libro di vampiri, è facile capire quale sia…
“Le notti di Salem”, di Stephen King.Il libro è servito, a cura di Enrico Zoi